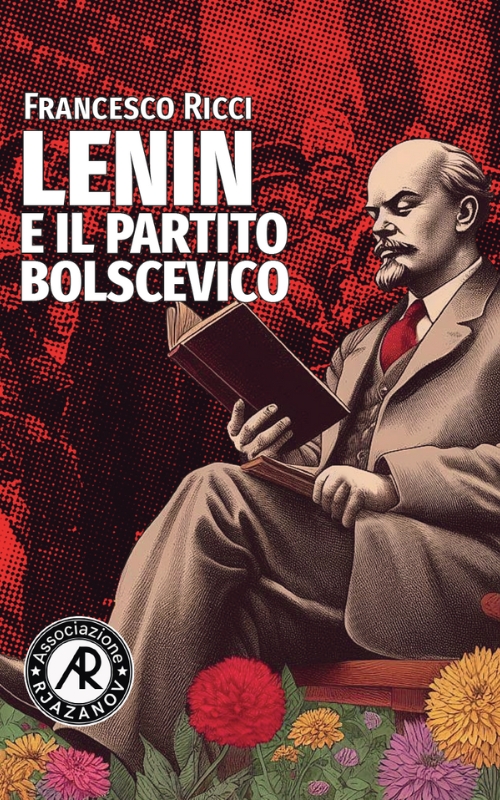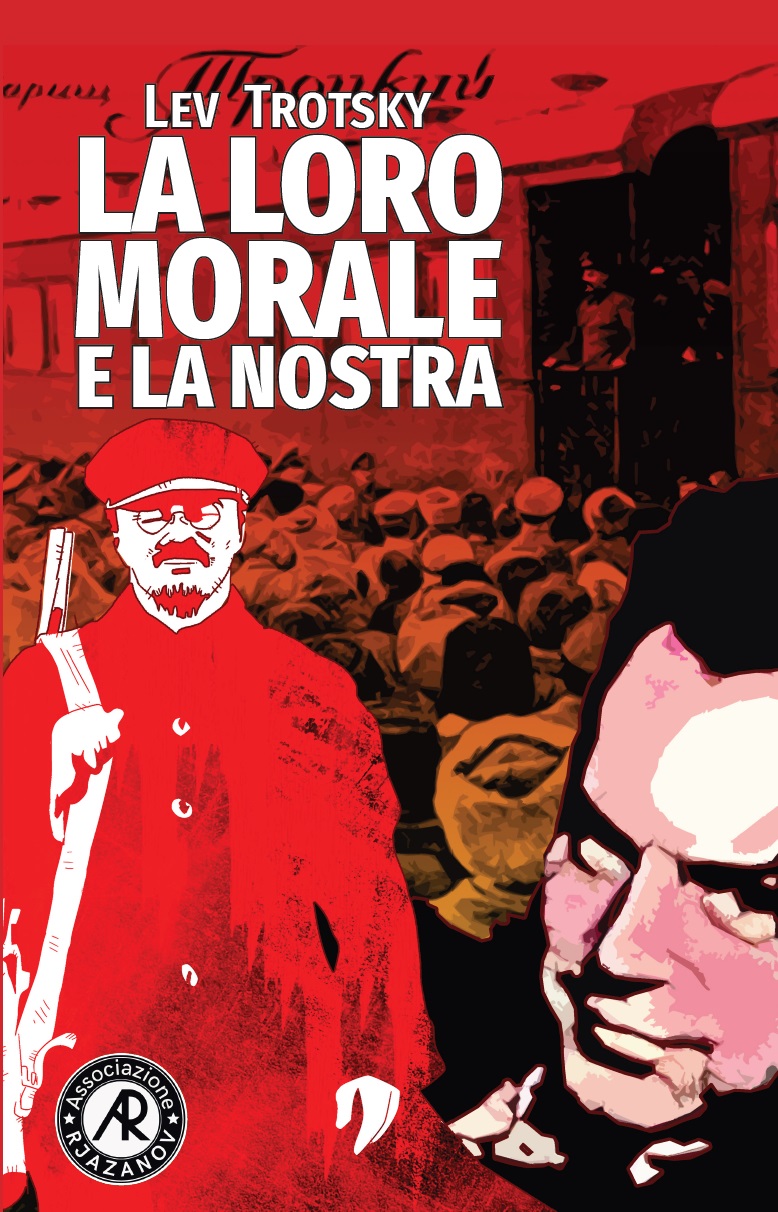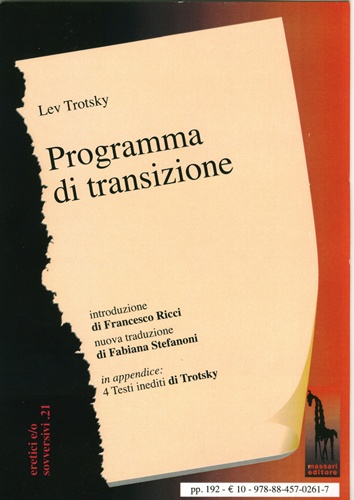Ex Libris
Gramsci prigioniero di Mussolini e Stalin
a cura di Fabiana Stefanoni
In occasione del settantesimo anniversario della morte di Gramsci, Giuseppe Vacca e Angelo Rossi, per conto dell'Istituto Gramsci, hanno pubblicato un libro, Gramsci tra Mussolini e Stalin (Fazi Editore), che offre importanti spunti di riflessione. Va detto, come premessa, che occorre avvicinarsi al libro con lo spirito di un investigatore; di chi, cioè, intende scovare, tra mille indizi fuorvianti, le prove veramente utili per arrivare a scoprire l'assassino. Prove che, guarda caso, sono quelle che i due autori intendono lasciare nell'ombra, soffocate da cataste di fantasiose congetture, supposizioni difficilmente verificabili e ricostruzioni storiche talvolta imprecise. È per far piazza pulita di tutto il superfluo e scoprire, invece, ciò che veramente conta che noi cominceremo qui a leggere il libro dalle ultime pagine.
Il "Rapporto Gennaro" e la "Riservata Gennaro"
Nell'appendice del libro, Vacca e Rossi pubblicano due testi inediti ritrovato negli archivi di Mosca, di cui, a detta dei due storici, si ignorava l'esistenza: il rapporto scritto per il Partito scritto dal fratello di Gramsci, Gennaro, dopo la visita al prigioniero, a Turi, nell'estate del 1930; una lettera riservata dello stesso Gennaro ai vertici del PcdI. Gli elementi nuovi che emergono da questi scritti sono due: Gramsci era molto "in collera" con il partito per la lettera che Grieco gli aveva inviato in carcere nel 1938 e che fu per lui "il più grave capo d'accusa"; Gramsci approvava l'espulsione dei tre trotskisti italiani dal PcdI e comunicava la decisione di richiedere un'autorizzazione speciale per la lettura dei testi di Trotsky.
Per quanto riguarda la lettera di Grieco a Gramsci, è ormai certo che la missiva, scritta nel febbraio del 1938, fu approvata da Mosca: in essa, Grieco esaltava Gramsci per il suo ruolo dirigente del partito e questo, agli occhi dello stesso Gramsci, fece saltare le trattative in corso per la sua liberazione. È noto che la lettera non arrivò mai al destinatario, ma gli fu letta dal giudice Macis che, come riportato nel "Rapporto Gennaro", commentò: "Vede bene On. che non a tutti rincresce che ella rimanga in carcere". Come Rossi e Vacca sono costretti ad ammettere, nonostante il goffo tentativo di giustificare la buona fede di Togliatti, "non vi possono essere più dubbi, quindi, sul fatto che dalla fine del '32" come emerge da una lettera del 5 dicembre 1932 a Tania (la cognata) "Gramsci indicasse in Togliatti l'ispiratore della lettera di Grieco" (p. 164). Tutto questo va associato al fatto che, nell'autunno del 1927, gli sforzi intrapresi dai dirigenti stalinisti per la liberazione di Gramsci erano ridicoli: si propone a Mussolini lo scambio con "qualche sacerdote cattolico detenuto nelle prigioni russe" (si veda la lettera di Manuilskij a Bucharin, citata a pag. 17). Ovviamente, Mussolini risponde picche.
Tutto questo fa pensare a una precisa volontà degli stalinisti di tenere in carcere Gramsci. Ma, una volta trovati gli indizi, occorre individuare un possibile movente. Per questo, dobbiamo rivolgere l'attenzione alla congiuntura in cui questi fatti si verificarono. Siamo alla fine degli anni Venti, quando a Mosca è in atto la resa dei conti tra Stalin e l'Opposizione di sinistra, che si conclude con l'espulsione di Trotsky dal partito nel novembre del 1927. Gramsci nell'autunno del 1926 scrisse due lettere, una a nome dell'Ufficio Politico del PcdI al Comitato Centrale del Pc russo; una personale a Togliatti. Nella prima egli si schierava con la maggioranza russa (Stalin e Bucharin) contro le opposizioni, ma invitava Stalin a "non stravincere"; nella lettera a Togliatti, il quale sottolineava la necessità di "aderire senza limiti" alla linea della maggioranza, scrisse senza mezzi termini "il tuo modo di ragionare mi ha fatto un'impressione penosissima". Fu di poco successivo l'arresto di Gramsci, una manna dal cielo per lo stalinismo: ci sentiamo di condividere l'affermazione dei due storici quando sostengono che, in quel contesto, Gramsci "una volta libero avrebbe rappresentato un problema in più per Stalin" (p. 12). Se a questo si aggiungono le critiche di Gramsci al cosiddetto "Terzo periodo" e alla linea del "socialfascismo"[1] (critiche in parte analoghe a quelle di Trotsky) - critiche che inducono il collettivo comunista del carcere a emarginarlo e addirittura a chiederne l'espulsione dal Partito - ben si comprende perché allo stalinismo Gramsci facesse più comodo come innocua icona e invitato fantasma ai congressi dell'IC che come autorevole (e scomodo) dirigente in carne ed ossa.
Gramsci "trotskista"?
L'altro elemento nuovo che emerge dal "Rapporto Gennaro" è la condivisione, da parte di Gramsci, dell'espulsione, avvenuta nel giugno del 1930, di Tresso, Leonetti e Ravazzoli, cioè dei tre referenti di Trotsky in Italia: "Nino mi disse di non preoccuparmi troppo del caso Feroci (Leonetti, ndr) e C. Essi non sono altro che delle perfette nullità, e molto probabilmente hanno agito per sola vanità". Similmente, Gramsci si sarebbe detto per nulla stupito dell'espulsione di Tasca e Bordiga (avvenute negli stessi mesi). È ovvio che le informazioni che Gramsci aveva in carcere erano limitate, sia sull'espulsione dei "tre", sia, più in generale, sulla battaglia di Trotsky: di qui, la sua decisione di leggere direttamente gli scritti di quest'ultimo (gli verrà concessa solo l'autobiografia, tradotta in quegli anni dalla Mondadori). Altrettanto ovvio è il fatto che fu proprio la necessità di non trovare ostacoli sulla strada della definitiva resa dei conti, anche in Italia, con il trotskismo che indusse Togliatti a mandare Gennaro a Turi per "estorcere" un via libera.
Al di là di questo fatto, le relazioni tra Gramsci e il trotskismo sono più complesse di come Togliatti ha cercato di liquidarle (Togliatti nel 1953 dichiarò che Gramsci "dette dal carcere il suo consenso alle misure più severe", cosa che non risulta dal "Rapporto"). Allo stesso tempo, tuttavia, sono riduttive e semplificate le letture di chi vorrebbe vedere in Gramsci un sostenitore della battaglia di Trotsky, un "trotskista" di fatto[2]. Vale la pena di fare un accenno, in questa sede necessariamente limitato, alle vicende che precedono le già citate lettere di Gramsci dell'autunno del 1926.
Gramsci ebbe, nelle prime fasi di vita del Partito comunista d'Italia (nato a Livorno nel 1921, da una scissione dal Psi), un ruolo relativamente secondario rispetto a Bordiga, allora segretario del partito. Fin da subito, emersero discordanze tra la linea bordighiana del PcdI e quella dell'Internazionale comunista di Lenin e Trotsky. Fu proprio Trotsky a gestire, in particolare a partire dal III Congresso dell'Internazionale, i rapporti con la sezione italiana: la polemica, spesso accesa, verteva sulla tattica del fronte unico, poiché, per dirla con Trotsky, nei comunisti italiani vi era una "insufficiente comprensione del nostro compito principale, vale a dire la necessità di conquistare l'avanguardia della classe operaia"[3]. Il settarismo e l'ultrasinistrismo dei comunisti italiani portò ad alcuni momenti di forte tensione nel 1922, in occasione del II Congresso del PcdI e del IV Congresso dell'IC. Va ricordato che nel 1922 Gramsci era a Mosca e vi rimase fino al novembre del '23, dove fu oggetto di attenzioni da parte dei dirigenti dell'IC, per convincerlo a mettere in discussione l'ultrasinistrismo di Bordiga. Nel frattempo, cominciava ad emergere la figura di Togliatti, fino ad allora, nonostante la diversa provenienza politica (Togliatti proveniva, come Gramsci, dal gruppo dell'Ordine Nuovo), allineato alle posizioni di Bordiga. Il gruppo di Togliatti cominciò a porsi a metà via tra l'IC e Bordiga.
Per tutto il 1924, Gramsci non prese una posizione netta. Nel frattempo, cominciava - e questo è un passaggio fondamentale per capire la collocazione di Gramsci rispetto al dibattito internazionale - la cosiddetta "svolta zinovevista" nell'IC, con la connessa accesa polemica Trotsky-Zinovev sulla rivoluzione permanente. Nel giugno del 1924, ebbe inizio il V Congresso dell'IC, dominato dal trio Stalin-Zinovev-Kamenev (la troika), in polemica con Trotsky a partire dalle critiche che quest'ultimo aveva mosso alla loro politica in relazione alla Germania. È qui, in funzione "antitroskista", che la troikaStoria dell'Internazionale comunista, "direzioni devote alla direzione staliniana e capaci di demolire ogni opposizione reale e potenziale". Non solo: al V Congresso si cominciò a mettere in discussione tutto l'impianto dei quattro congressi precedenti, compresa la tattica del fronte unico. Cominciò al V Congresso l'alleanza di ferro tra Stalin e Togliatti: la bolscevizzazione significava anzitutto consolidamento del potere di Stalin ed emarginazione degli elementi considerati pericolosi per esso. L'anno dopo (1925), al V Esecutivo allargato dell'IC, cui partecipò anche Gramsci, venne posta la questione della "stabilizzazione capitalistica", connessa alla formula, elaborata da Stalin qualche mese prima, del "socialismo in un paese solo". Stalin chiese agli italiani una presa di posizione sul trotskismo, affidata a Scoccimaro (su mandato del CC del partito). Gramsci, pur esprimendo fin da subito, a differenza di Togliatti, riserve sulla teoria del socialismo in un paese solo, rivendicò tuttavia la giustezza della linea della "bolscevizzazione" (si veda la sua relazione al CC del PcdI dell'11 maggio 1925). Solo Bordiga, che pure aveva votato a favore della svolta del 1924, prese nel 1925 una esplicita posizione a difesa di Trotsky. diede il via alla cosiddetta "bolscevizzazione", cioè all'intervento diretto nella definizione dei quadri dirigenti delle sezioni nazionali, col tentativo di rendere monolitici i partiti nazionali, ponendo alla loro testa, come scrive Frank nella
È in questo quadro che si collocano le celebri "Tesi di Lione", le tesi del III Congresso del PcdI (gennaio 1926), che presentavano un carattere contraddittorio. Da un lato, costituivano il superamento dei precedenti limiti d'impostazione politica della sezione italiana, con l'acquisizione, grazie all'apporto di Gramsci, di un approccio transitorio (nonostante alcune accentuazioni "oggettiviste" e "nazionaliste"); dall'altro lato, furono redatte all'insegna della "bolscevizzazione", con l'evidente intento di azzerare l'opposizione di Bordiga (che in quel momento difendeva Trotsky), nei cui confronti vennero utilizzati metodi poco corretti (falsificazioni, sospensioni di dirigenti ecc), tanto che Gramsci ottenne addirittura il 90,8% dei consensi, mentre fino a pochi mesi prima Bordiga controllava le principali federazioni.
Un tentativo di conclusione
Le prese di posizione immediatamente successive di Gramsci, lasciano comunque intendere, da parte sua, una relativa critica alla politica di Stalin, di cui invece Togliatti era ligio esecutore. Ciononostante, è giusto comprendere la figura di Gramsci senza lasciarsi trasportare dalla facile tentazione di attribuirgli posizioni che non furono sue. Senza dubbio, è ignobile che gli stalinisti di tutti i tempi abbiano preteso di richiamarsi al suo pensiero, quando fu proprio Stalin a impedirne la scarcerazione. Cercando di trarre un bilancio parziale, è forse corretto dire che Gramsci fu, per un breve periodo, un alleato "critico" di Stalin nella battaglia contro Trotsky; ma di cui Stalin si sbarazzò subito dopo, come fece con tanti altri suoi alleati: nel caso di Gramsci, perché egli, a differenza di Togliatti, non era disposto a rinunciare alla sua battaglia politica, comunque inconciliabile col revisionismo e col gradualismo riformista, per la cieca fedeltà a una cricca di burocrati: è per questo che nessun tentativo reale fu fatto in funzione della sua liberazione.
[1] Cioè l'equivalenza tra socialdemocrazia e fascismo o addirittura la maggiore pericolosità della socialdemocrazia rispetto al fascismo, con il conseguente rifiuto della tattica del fronte unico.
[2] Faccio riferimento, in particolare, ai limiti di certe letture antistaliniste, a partire da Livio Maitan e Antonio Moscato.
[3] Si veda L. Trotsky, Scritti sull'Italia, Massari editore, 1990, p. 55.